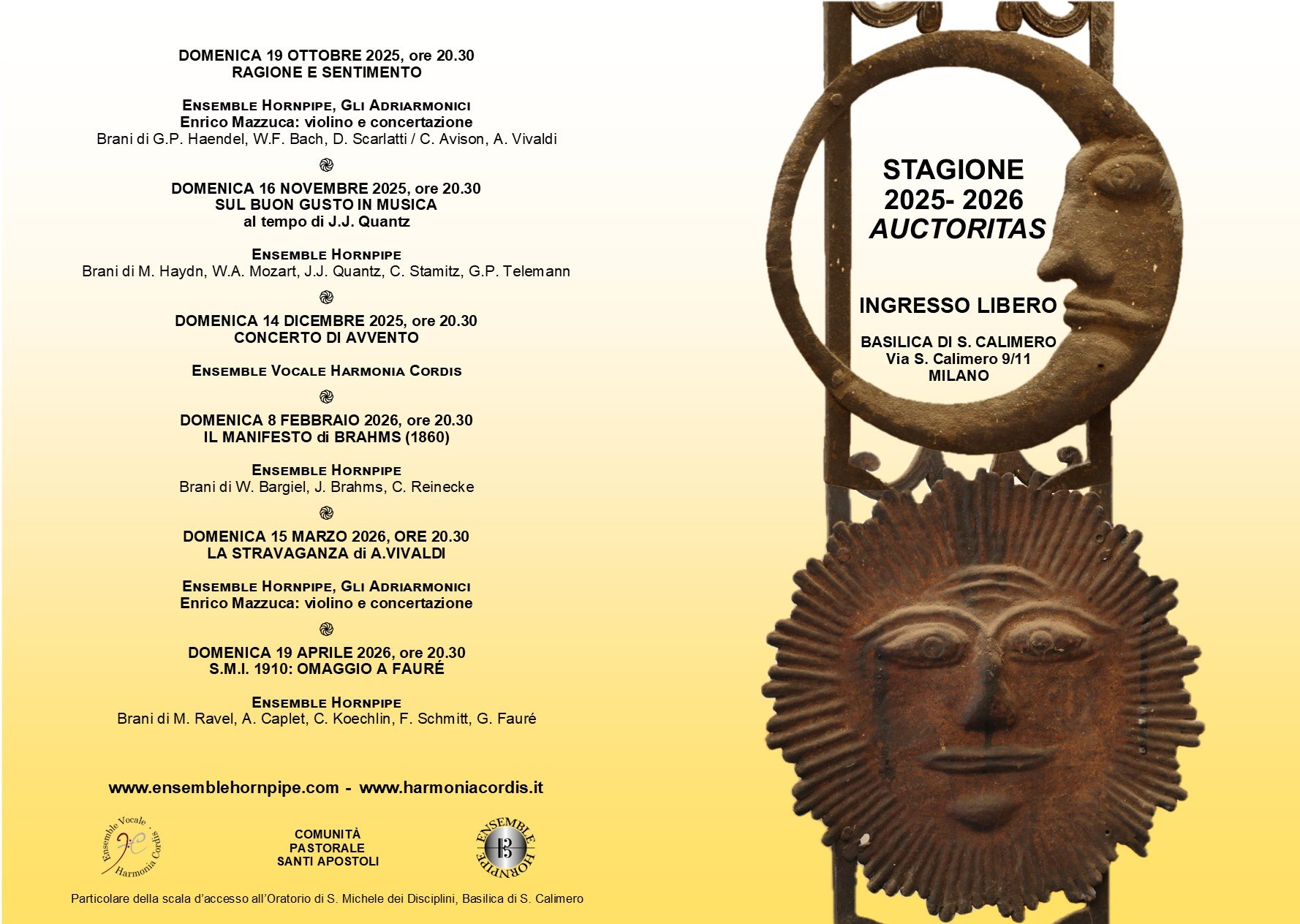La stagione 2025-2026, celebrativa dei nostri venti anni di attività musicale presso la Comunità Santi Apostoli e la Basilica di S. Calimero, è dedicata al tema dell’autorevolezza. Un percorso che incrocia diversi concetti, tutti legati dalla comune radice latina auth-: autorità, autorevolezza, autore. Una radice riferibile, peraltro, anche al verbo Augere, che significa aumentare: perché l’autorevolezza contribuisce all’aumento del valore. Ma chi crea autorevolezza? L’autore, anche quando si tratta magari di nomi di più difficile ascolto? O l’autorità, ovvero le istituzioni, i maestri, e tutti i gelosi custodi e censori dello stile?
Partiremo da Johann Joachim Quantz, musicista e flautista tedesco, autore di un Saggio sul metodo per imparare a suonare il flauto con molte annotazioni sul buon gusto in musica, apparso nel 1752. In esso il compositore si interroga sul giudizio musicale e in particolare su come il pregiudizio su un compositore, e quindi la fama legata al suo nome, siano spesso elementi che predispongono il pubblico a un ascolto ‘premiante’: basterebbe quindi la fama dell’autore a decretare il successo di una composizione, più che la qualità. Il tema degli autori minori, e delle composizioni di rara esecuzione, ci è da sempre caro: assecondando il desiderio di Quantz eseguiremo quindi i brani di un concerto di autori del suo tempo senza svelare i nomi dei compositori di ciascun brano, per verificare se il giudizio del pubblico si basi più sulla fama o sull’ascolto.
Nel XIX secolo emerge con forza il ruolo dell’accademia, come istituzione di formazione ma al contempo come autorità capace di stabilire il valore di un musicista, attraverso concorsi, ammissioni, premi e spesso anche attraverso l’affermazione di un ideale estetico. Sarà per la difesa di questo ideale dagli attacchi che Johannes Brahms, nel 1860, firma insieme a W. Bargiel, A. Dietrich, C. Reinecke e F. Hiller una lettera di aperto dissenso contro i compositori e i loro allievi “della cosiddetta Nuova Scuola Tedesca, che in parte non fanno altro che rafforzare questi principi nella pratica e in parte rafforzano teorie nuove e inaudite, contrarie allo spirito più profondo della musica, da deplorare e condannare fermamente”. Il tema della controversia era il predominio della musica ‘pura’ – quella basata sui soli elementi musicali e forme accademiche come la fuga e soprattutto la sonata – contro autori come Liszt, Wagner e Berlioz che avevano introdotto forti elementi extra-musicali a sostegno di forme più libere, soprattutto nell’ambito del poema sinfonico. Sarà dalle pagine di Brahms, di Reinecke, di Bargiel che ci immergeremo in questo ideale, per chiederci se l’autorevolezza venga in effetti dall’accademia (custode della pura forma) o dalla novità dello spirito radicale.
Perché anche l’accademia stessa diviene, in alcuni casi, una gabbia: a inizio ‘900, in Francia, era l’accademica con il prestigioso Prix de Rome ad arrogarsi l’autorità di decretare quali compositori avrebbero dovuto avere successo e quali no. È celeberrimo il caso di Maurice Ravel, respinto cinque volte al Prix de Rome: a lui è dedicato il film di Anne Fontaine, uscito nel 2025. Meno noto il fatto che egli, insieme a L. Aubert, A. Caplet, R. Ducasse, J. Hure, C. Koechlin, F. Schmitt fondò nel 1910 la Societé Musicale Indépendante, che non solo promuoveva i giovani autori dando loro la possibilità di essere eseguiti al di fuori dei concerti accademici, ma che nel 1911 (per cercare di vincere il pregiudizio del pubblico) promosse anche un concerto ‘senza autori’, per le ragioni sopra esposte. Alla musica di questi “giovani”, e all’omaggio che molti di essi resero al loro presidente e docente (stimato per la sua libertà di vedute e per la sua autorevolezza, in grado di cambiare le sorti di tanti musicisti), dedicheremo un concerto di brani a cavallo tra le due guerre mondiali.
Il tema della libertà espressiva e il gusto per la rottura delle forme emergeranno anche con il concerto dedicato a La Stravaganza Op.4 di Antonio Vivaldi: pubblicata tra il 1712 e il 1713, è dedicata a Sua Eccellenza il Signor Vettor Delfino, nobile veneto, perché con la sua autorevolezza “lo diffenda dalla garrulità dei maligni e dalla troppo affettata severità dei critici”.
La stagione viene completata dal concerto d’Avvento, come sempre a cura dell’Ensemble Vocale Harmonia Cordis, e da una speciale serata musicale (inaugurale di questo percorso) che celebri il nostro desiderio di suonare, di ricercare e di divulgare proponendo un punto di vista originale sul mondo della musica accademica, libero da condizionamenti che non siano quello davvero imprescindibile: l’autorità che il pubblico ci concede, seguendoci da venti anni.
LUCA VONELLA